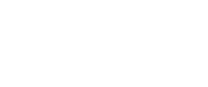Di che pasta è fatta la non-arte?
Marco Senaldi
Sorprendentemente Duchamp non amava essere preso per un anti-artista, ma sosteneva di essere un non-artista. Infatti, l’anti-artista è come l’ateo, che nega dio, perché sotto sotto, anche se a rovescio, ci crede ancora, mentre il non-artista non crede e basta — cioè non crede nell’Arte con l’A maiuscola, dubita insomma dell’identità dell’arte.
A furia di negazioni oggi quell’Arte maiuscola non esiste veramente più e lo sviluppo dell’arte contemporanea va di pari passo con la sua estraneazione nel mondo reale. E’ arte pubblica, impegnata, realista, appropriazionista, televisiva, ecc., ma proprio nel suo negarsi resta ancora misteriosamente arte. Perché?
Come molte altre forme spirituali, anche l’arte è passata dall’occupare un luogo simbolico, di legittimazione dei suoi prodotti e dei suoi adepti, ad un luogo immaginario, di rovesciamento e di inversione del proprio fare. Se prima dunque l’arte legittimava chi la faceva come “artista” e ciò che faceva come “arte” (di cui l’anti-arte era la nemica), oggi non è più così. La lunghissima lotta intrapresa dalle avanguardie prima e poi da tutti i movimenti del dopoguerra, nessuno escluso, per cambiare il significato, la natura, l’essenza dell’arte, ha avuto finalmente successo. Le cose sono andate un po’ come per la Coca Cola, che dopo tanti anni di esaltazione pop, e dopo tante lotte per distruggerla, ha finalmente prodotto la non-Coca Cola, la Diet Coke, che è Coke-free rimanendo Coke. Ossia, dopo tante lotte contro l’essenza senza parvenza e contro la parvenza senza essenza, abbiamo l’essenza nel suo stadio rovesciato, che appare come il contrario di se stessa, e nondimeno resta se stessa negandosi.
Lo stesso esempio si può applicare all’arte, di cui quella contemporanea non rappresenta il pezzo più recente, ma la scrupolosa quanto totale ri-flessione. In sostanza, tutta la foga distruttiva nei confronti dell’arte esercitata precisamente da artisti e in definitiva dall’arte stessa, non significava veramente lo sbarazzarsi dell’ingombrante fardello di un’arte vecchia a favore di un’arte nuova, ma piuttosto ha avuto lo scopo (spesso inconsapevole) di operare una transustanziazione del corpo mistico dell’arte stessa, riducendolo ad essenza inversa di se stessa.
La non-arte che ne è derivata non è dunque il frutto bastardo di un incrocio fra il mondo aulico dell’Arte e quello spurio del mondo “là fuori”, ma è il distillato purissimo della più alta riflessione dell’arte su se stessa — una diet-art che risulta art-free rimanendo art. Non potendo esercitare altro che questa riflessione, poiché come attività di adeguamento simbolico essa era già terminata all’epoca hegeliana, l’arte ha divorato se stessa. Nel momento in cui, forse proprio con Duchamp, o forse molto prima, essa ha coinciso con la propria definizione, ha firmato il proprio testamento spirituale. Da allora, l’arte è divenuta un fatto immaginario, ossia un esercizio di legittimazione contraddittoria. La non-arte non è il mondo della vita, i barattoli del supermercato o i sassi della strada messi in galleria, o la lotta contro il potere tradotto in belle immagini per le riviste tipo “Artforum”. E’ e rimane arte, ma in modo doppiamente rovesciato, identità di una forma spirituale guadagnata a forza di negazioni, intese come momento dialettico di definizione reciproca. Definire ciò che è o ciò che non è, arte, è non solo il compito, ma l’essenza stessa dell’arte contemporanea in quanto arte-non-arte dei nostri tempi, in quanto essenza due volte rovesciata — e pertanto vera.
La non-arte è caratterizzata così dalla costante inversione dell’esser-posto di ogni cosa a cui sia allegato un valore simbolico e una identità: così, se quella cosa è definita come “arte”, essa sarà immeditamente anche “altro-dall’arte” (Brillo Box, gioco, divertissement, simulacro, ecc. ecc.), mentre, se è “altro dall’arte”, potrà essere compresa solo in quanto appartenente all’ambito “arte” (ready-made, installazione, performance,…); senza che sia comunque mai possibile evitare questa continua transizione paradossale da un termine di riferimento all’altro.
Questo sussistere della contraddizione entro la cosa, ed il suo reiterarsi senza risolversi, è ciò che si può definire il livello immaginario dell’arte, o anche il suo statuto di doppia inversione, ossia di obversione. Il punto da non perdere, tuttavia, è che l’immaginario non è affatto qualcosa di fantasioso o di onirico, o di surrealmente lontano dalla “realtà”. La malleabilità, per esempio è uno dei caratteri dell’immaginario. Non è certo un caso che un artista interessato allo spazio, come Lucio Fontana, abbia impiegato a più riprese un materiale come la ceramica per produrre quegli strani oggetti che stanno a metà strada tra le sue tele spaziali e la decorazione. Lo spazialismo si fonda sulla malleabilità di qualcosa di concettualmente rigido come lo spazio, come insegnano gli spazi plastici di Giò Colombo. Prima di loro i futuristi erano stati i pionieri della riscoperta del materiale ceramico, forse proprio perché avevano parlato di “ricostruzione futurista dell’universo” e perché, tra le loro folli ricette di cucina avevano incluso un “carneplastico”.
Certo, la plastica era stata il materiale ideale dell’immaginario, quello grazie a cui i sogni impossibili di oggetti indeformabili, di bicchieri che non si possono infrangere, di contenitori virtualmente eterni e multicolori, erano diventati realtà. Ma l’immaginario è anche ricorsivo, torna sulle sue stesse dimenticanze, non accettando che i suoi ricordi svaniscano, che qualcosa cada fuori dal suo orizzonte di recupero. La plastica è divenuta presto il materiale principale della nostra realtà, così come doveva essere il legno nel Medioevo, o il ferro nell’Ottocento industriale, al punto che oggi la ceramica non ne rappresenta il progenitore, ma un succedaneo che porta in sé, come valore “di recupero”, anche caratteristiche da cui in un primo tempo avevamo cercato di sbarazzarci, come la fragilità, la difficoltà di lavorazione, la preziosità, ecc.
Il tratto caratteristico della nostra non-epoca è che l’arte che essa esprime, in quanto non-arte, trascina con sé certi valori appartenenti al passato — come manualità, imitazione, qualità artigianale, ecc. — valori che proprio in quanto “superati” divengono oggetto di recupero, come quelle specie che, appunto perché in via d’estinzione, devono essere protette. Questa forma di recupero riflessivo rende ragione del fatto che la quasi totalità delle opere realizzate dagli artisti invitati a questa 1° edizione della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea, abbia la caratteristica della non-identità. Benché gli artisti presenti in mostra appartengano agli ambiti più diversi e perseguano poetiche strettamente personali, il loro rapporto con un materiale antico ma futuribile, in quanto post-plastico, come la ceramica, dà vita a veri e propri non-oggetti, cioè ad oggetti che sono insieme più e meno di se stessi.
I caschi “fragili” (e pertanto dis-utili) di Cecchini, le pseudo-parrucche di Nina Childress, il simil-pelouche della Torimitsu, le amigdale fasulle di Vitone, il cuscino “rigido” di Perino e Vele, la torta non commestibile di Costa Vece, il tombino “da salotto” di Sisley Xhafa, gli ellepì impossibili (eppure funzionanti!) di Daniel Firman, la carta di credito mimetica ma, ahimé ceramizzata, di Pancrazzi — tanto per citare — sono esempi perfetti di questa eccedenza e insieme carenza costitutiva, perché sono opere che possono essere dette “d’arte” meno in ragione dell’appartenenza ad una tradizione culturale che per essere frutto di una sapienza artigianale. In definitiva, sono non-oggetti prodotti da una volontà non-artistica — sono fatti controfattuali, paradossi reali, contraddizioni in termini.
Verso questi non-oggetti occorre esercitare una commossa simpatia perché ci assomigliano “più di quanto noi stessi non potremmo mai assomigliarci” — perché, come dei falsi fossili, rappresentano non tanto la nostra storia, ma la nostra storia come vorremmo che fosse raccontata. Reperti dell’immaginario, né sovversivi, né perversi, ma piuttosto obversi, essi spiegano molto bene la nostra attuale condizione di non-individui, di soggetti “con le ossa rotte” — ma nondimeno impegnati a ricostruirsele, magari col fragilissimo materiale della ceramica.